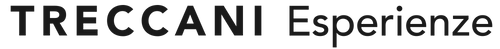Quella della grappa è una storia che affonda le radici in un passato lontano, un’evoluzione segnata da passaggi e cambiamenti, con un futuro tutto da scrivere. La grappa, nella sua definizione ufficiale, è l’acquavite di vinacce ricavate da uve prodotte esclusivamente in Italia e lavorate solamente in distillerie situate sul suolo italiano: anche in altri Paesi si producono alcune acquaviti a partire dagli stessi ingredienti, ma hanno caratteristiche proprie e assumono nomi diversi, come ad esempio il Marc francese.
La grappa appartiene al mondo delle acquaviti, nell’ambito del quale si distingue per la materia prima di partenza, le vinacce appunto, rispetto ad altri prodotti come le acquaviti da vino (brandy, cognac, armagnac), da cereali (whisky e in parte vodka e gin), da canna da zucchero (rum). Anche se è a Monte Grappa che si concentrano alcune delle più note distillerie italiane, l’origine del nome non è geografica: grappa deriva infatti dal raspo dell’uva, in lombardo grapa, e dunque ogni acquavite di vinacce prodotta in Italia ha diritto a definirsi così, indipendentemente dalla regione di origine, mentre solo alcune possono esibire il marchio di Denominazione di origine protetta (DOP).
L’origine della grappa è da ricercare in quella cultura contadina che riutilizza tutto e trasforma con ingegno e fantasia gli scarti in nuovi prodotti: le vinacce, infatti, sono i residui della produzione del vino e comprendono le bucce e i vinaccioli, cioè i semi. La grappa nasce dunque come ‘invenzione’ povera: mentre aristocratici e proprietari terrieri bevevano il vino e magari il distillato di vino, i contadini riutilizzavano anche le vinacce, in diversi modi. Uno dei più diffusi era quello di ricavarne, con l’aggiunta dell’acqua, una bevanda chiamata ‘vinello’. Un’alternativa più impegnativa era quella di produrre la grappa tramite la distillazione: le vinacce fermentate venivano scaldate ottenendo la separazione delle parti volatili, alcoliche e aromatiche e queste, in seguito condensate e ridistillate, davano vita al prodotto finito.
La pratica della distillazione è molto antica: si trovano tracce di attività di questo tipo nelle civiltà della Mesopotamia e dell’Egitto, dove venivano utilizzate per scopi medici o per l’imbalsamazione. Un contributo importante allo sviluppo della distillazione lo dette la Scuola medica salernitana nel IX secolo, dove si sperimentò l’utilizzo dell’acquavite per scopi terapeutici, in primo luogo come solvente per i principi medicinali. Le fonti attendibili sulla distillazione delle vinacce sono più tarde e risalgono al Basso Medioevo, come ad esempio il trattato De Conficienda Aqua Vitae del medico padovano Michele Savonarola (1384 -1462). Anche per i secoli successivi le fonti sono scarse: è possibile però che trattandosi di un prodotto consumato dalle classi popolari, le tracce scritte siano molto successive rispetto all’effettiva produzione.
Per molto tempo in alcune zone del Piemonte, della Lombardia e del Veneto agirono i grapat, una sorta di artigiani ambulanti. Andavano nelle zone di forte tradizione vinicola, portandosi rudimentali alambicchi su una carriola attrezzata e, sfruttando la materia prima accantonata dai contadini e utilizzando la distillazione a fuoco diretto, producevano grappa a domicilio. Il primo a rinnovare la tradizione dei grapat fu uno di loro: Bartolo Nardini, che - giunto a Bassano del Grappa - acquistò l’Osteria al Ponte e fondò nel 1779 la sua grapperia. Per la prima volta non era più il grapat a recarsi di casa in casa dai contadini con la sua attrezzatura mobile, ma erano i contadini a recarsi nella sua officina a portargli le vinacce per produrre la grappa, che Nardini definì Aquavite di vinaccia. Nel 1860, grazie all’impulso del nipote del fondatore, la grapperia Nardini introdusse la distillazione a vapore al posto della tradizionale distillazione a fuoco diretto. La nuova tecnica è stata adottata nel tempo dalla maggior parte delle aziende del ramo, poiché garantisce un più facile controllo sul prodotto finale, anche se alcune grapperie artigianali sono rimaste legate al sistema a fuoco diretto.
La grappa fu ampiamente consumata dai soldati al fronte durante la Prima guerra mondiale, per combattere il freddo ma anche il giustificato timore che precedeva gli assalti. Ritenendo che dopo aver bevuto grappa i soldati affrontassero i pericoli con più coraggio, o se vogliamo con più incoscienza, erano gli stessi comandi militari a organizzarne la distribuzione, e furono in molti a consumare per la prima volta questo prodotto in quelle terribili circostanze.
Negli ultimi decenni, parallelamente all’evoluzione del gusto del pubblico, divenuto più esigente, c’è stato anche un cambiamento della qualità della grappa, che è andata raffinandosi attraverso la ricerca e le modifiche dei sistemi di produzione. Una strada che ha determinato anche lo sviluppo di un mercato di esportazione crescente, in direzione soprattutto della Germania e degli Stati Uniti. L’avventura della grappa continua: sulla base della stessa originaria intuizione, si sta affermando un prodotto piuttosto differente rispetto ai suoi lontani antenati; eppure, la sua storia di adattamento, di lavoro e di ingegno contribuisce ancora oggi a conferirle tutto il suo immutato fascino.