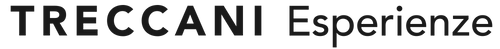La Versilia custodisce nel suo territorio preziosi lasciti del periodo mediceo e dell’attiva presenza di Michelangelo Buonarroti. Fu proprio Michelangelo a contribuire alla realizzazione di quel tratto di strada che dalle cave di Trambiserra sul monte Altissimo - passando per Seravezza, Corvaia e Querceta - conduceva fino a Forte dei Marmi, dove il marmo veniva poi imbarcato e trasportato a Firenze risalendo il corso dell’Arno. È l’antica via dei Marmi, il cui percorso è ancora oggi seguito dall’attuale via Provinciale.
Il fascino e la storia di quest’area sono indissolubilmente legati al marmo: la materia viva custodita nelle viscere del territorio che più ha incarnato l’aspirazione umana all’arte e alla bellezza. E la strada dei marmi sembra collegare non soltanto una montagna con il mare, una cava con una città ricca di fermenti, ma anche la materialità del mondo con forme che solo l’arte può donare.
Giovanni de’ Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico salito al soglio pontificio come Leone X nel 1513, aveva subito deliberato il passaggio della Versilia a Firenze, sottraendola al dominio di Lucca. In occasione della sua visita a Firenze del 1516, la facciata ancora incompiuta della Basilica di San Lorenzo era stata provvisoriamente ricoperta di apparati effimeri realizzati da Jacopo Sansovino e Andrea del Sarto. Un allestimento questo che non soddisfaceva il gusto raffinato del pontefice, considerato dai contemporanei attratto più dalla cultura e dall’arte che da preoccupazioni spirituali. Leone X decise quindi di indire un concorso per il completamento della facciata di quella chiesa così legata alla storia della sua famiglia da ospitare le tombe dei suoi membri più influenti, a partire da Cosimo il Vecchio. Parteciparono alcuni tra i maggiori artisti dell’epoca come Raffaello, Giuliano da Sangallo e appunto Michelangelo, che illustrò il suo progetto con numerosi disegni e due modelli lignei proponendo, non una composizione di elementi singoli, ma una totalità organica e fortemente plastica.
Leone X gli affidò l’incarico nel 1518, ma anziché dei marmi che giungevano da Carrara, pretese l’utilizzo dei marmi estratti nell’area di Seravezza sul monte Altissimo, territorio da poco entrato nel dominio dei Medici. Michelangelo, da parte sua, apprezzò la qualità dei marmi provenienti da tale zona, che definì “di grana unita, omogenea, cristallina”, paragonandoli allo zucchero.
La difficoltà era piuttosto nel trasferimento del materiale fino a Firenze, lento e addirittura pericoloso. Michelangelo stesso rischiò di morire nel settembre 1518 quando, durante il trasporto su un carro, un blocco di marmo si staccò e uccise un operaio che camminava accanto a lui. Il tragico avvenimento lo colpì profondamente, come risulta anche dalla sua corrispondenza; ed è probabile che proprio questo incidente lo abbia spinto a progettare e a presiedere alla realizzazione di una strada più agevole e più sicura, con l’importante collaborazione dello scultore Donato Benti: un’impresa che si protrasse per ben tre anni.
Ma quando il percorso fu finalmente utilizzabile e i primi marmi iniziarono a raggiungere Firenze, il progetto della facciata venne abbandonato e mai più realizzato: ancora oggi, il prospetto rimane spoglio, di sola pietra grezza. Michelangelo eseguì altri lavori nella basilica, tra cui la Sacrestia Nuova, destinata a ospitare le tombe di importanti esponenti della famiglia Medici, la Biblioteca Medicea Laurenziana e il balcone della controfacciata per l'esposizione delle reliquie. La strada dei marmi invece non fu abbandonata e anzi venne completata e ampliata nel 1567 per interessamento di Cosimo I de’Medici.
La cava è ancora attiva e, nonostante le difficoltà incontrate e la mancata realizzazione del progetto di facciata che aveva sollecitato la costruzione della strada, l’eredità della presenza di Michelangelo e dei Medici nell’area è tuttora molto sentita e caratterizzante. È ancora la magia del marmo a tenere insieme e collegare la storia, l’arte e la cultura di questo territorio. La Villa Medicea di Seravezza, fatta costruire per volere di Cosimo I come residenza temporanea per le frequenti visite alle cave di marmo e alle miniere di argento, è stata utilizzata nel periodo estivo prima dai Medici, poi dagli Asburgo Lorena e da altre famiglie nobiliari. Dal 2013 fa parte del Patrimonio mondiale dell’umanità tra le “Ville e giardini Medicei della Toscana” e rappresenta un ulteriore tassello di un ricchissimo mosaico.
Crediti della foto
Cava di marmo nell’area delle Alpi Apuane, provincia di Lucca.