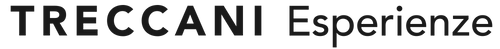Dopo questo egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi!». Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C’era una folla numerosa di pubblicani e di altra gente, che erano con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori?». Gesù rispose loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si convertano».
Luca, V, 27-29
Il giorno prima che si chiudesse il Concilio di Trento, nella XXIV sessione del 3 dicembre 1563, venne approvato il decreto De invocatione, veneratione et reliquis sanctorum et sacris imaginibus che stabiliva la necessità di un attento controllo su tutte le produzioni artistiche, in particolar modo quelle che riguardavano i luoghi di culto e i temi religiosi. I tribunali dell’Inquisizione dovevano vigilare soprattutto su dogmi e precetti che erano oggetto di controversia con gli eretici e i protestanti.
Durante la Controriforma, alle immagini che raccontavano la storia sacra nei luoghi pubblici di culto veniva attribuita una grande responsabilità pedagogica e i principali trattatisti controriformisti - tra cui Carlo Borromeo, autore delle Instructiones fabricae et suppellectilis ecclesiasticae, Gabriele Paleotti, che nel 1582 scrisse il Discorso intorno alle immagini sacre e profane, Molanus (Jan van der Meulen), Giovanni Andrea Gilio e Federico Borromeo - dettarono le regole affinché le arti figurative trattassero correttamente i temi religiosi. I criteri erano in primo luogo quelli della chiarezza, del rispetto del pudore e della corrispondenza con le Sacre Scritture. Due casi furono considerati esemplari e fornirono indicazioni e ammonimenti per gli artisti: la “vestizione degli ignudi” del Giudizio universale, disposta da Pio IV dopo la morte di Michelangelo nel 1564, e il processo cui fu sottoposto Paolo Veronese nel 1573, per la sua rappresentazione dell’Ultima cena poco rispettosa delle Scritture.
Il processo colse Paolo Veronese quando ormai si era affermato come artista di spicco in una società veneta in piena espansione, a cui contribuiva a dare rappresentanza, attraverso forme e colori. Paolo Caliari era nato a Verona nel 1528, da cui gli derivò il soprannome Veronese, con cui divenne celebre a Venezia, città in cui si stabilì a venticinque anni e dove proseguì una carriera ricca di riconoscimenti fino alla morte, nel 1588.
Di formazione vicina al Manierismo, sviluppò un suo stile personale che esaltava il disegno nella composizione delle figure, la luminosità, i colori limpidi e smaglianti. Nelle sue opere, spesso di grandi dimensioni, celebrava lo splendore e la potenza di Venezia e la ricchezza raffinata dell’aristocrazia veneta. Esemplari in questo senso sono le decorazioni di Villa Barbaro a Maser, dove accosta all’architettura reale del grande Palladio quella dipinta, creando un complesso gioco di illusioni: Veronese aggiunge alla villa con i suoi pennelli porte, balaustre, nicchie, e raffigura una magistrale bambina che si affaccia dalla porta.
I temi trattati nel corso della sua attività erano spesso a carattere religioso o mitologico, ma sempre inscritti in un’atmosfera festosa, luminosa, serena: uno sguardo che si modificherà soltanto nell’ultima parte del suo percorso, quando la sua pittura divenne più notturna, ricca di ombre, con temi religiosi ormai nettamente prevalenti e interpretati con correttezza tridentina. Un mutamento influenzato dal cambio generale di clima instaurato dalla Controriforma, dai primi segni di declino della potenza della Serenissima di fronte all’espansione ottomana, dagli effetti della pestilenza del 1576. Ma su questa evoluzione pesarono forse pure le accuse dell’Inquisizione, anche se da lui abilmente affrontate.
Veronese rappresentava spesso nelle sue opere dei banchetti; anche quando si ispirava a episodi biblici, non esitava a creare un clima mondano, con molti personaggi, vestiti eleganti, bambini che giocavano. Il banchetto veniva rappresentato come una festa, un’occasione per stare insieme gioiosamente. Quando gli venne commissionata un’Ultima Cena per il refettorio del convento domenicano dei Santi Giovanni e Paolo, in sostituzione di una tela di Tiziano distrutta da un incendio, Veronese mantenne il suo stile: un’ambientazione sontuosa, una folla di personaggi in abiti moderni, un buffone con un pappagallo, bambini, animali, servitori, guardie armate. Immagini che non corrispondevano alla sensibilità dell’epoca controriformista. Il pittore venne quindi convocato e interrogato dal tribunale dell’Inquisizione il 13 luglio 1573. I giudici sottolinearono subito che il soggetto del quadro non era una cena ma ‘la Cena’ di nostro Signore, da cui originava il sacramento dell’eucaristia. Gli contestarono la presenza di tedeschi armati (forse sospettando un omaggio alla Riforma luterana), il servo a cui sanguina il naso, un personaggio che usa la forchetta (piron) per pulirsi i denti, la presenza del pappagallo.
Veronese rispose con umiltà e forse anche con un po’ di timore, ma rivendicò la sua libertà di artista, precisando che «la commission fu di ornar il quadro secondo mi paresse»; i diversi elementi erano stati inseriti per motivi estetici, per riempire in modo creativo un grande spazio, «per ornamento, come si fa». E riaffermò lo status particolare di chi produce opere d’arte: «noi pittori ci pigliamo la licenza che si pigliano i poeti e i matti».
Di fronte a questa ingenuità così esibita che odorava di astuzia, il tribunale si ‘limitò’ a imporre al Veronese di emendare dal dipinto tutti gli elementi contestati, sopprimendo le figure indesiderate; le modifiche avrebbero dovuto essere realizzate a sue spese ed entro tre mesi. Ma è qui che l’artista manifesta ancora una volta il suo estro geniale, aggirando l’ostacolo a modo suo, e senza modificare la sua opera: stabilisce che il dipinto non rappresenta l’Ultima Cena, con la sua centralità teologica, ma il meno impegnativo Convito in casa di Levi, riportato nel Vangelo di Luca, brevemente. Peraltro, le Sacre Scritture precisano che nella casa di Levi erano presenti molti pubblicani e peccatori, ai quali può essere consentito di usare con disinvoltura il piron, farsi proteggere da guardie armate, divertirsi con i pappagalli. E forse anche ridere, giocare e vestirsi in modo elegante.
La soluzione accontentò tutti: il pittore, l’Inquisizione, i frati. La luce e i colori dei grandi banchetti però si stavano forse spegnendo.
Scopri la magia dell’arte di Paolo Veronese a Villa Barbaro a Maser: l’Esperienza Palladio Visionario ti aspetta.
Crediti della foto
Dettaglio del Convito a casa di Levi di Paolo Veronese, 1573, Sailko, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons