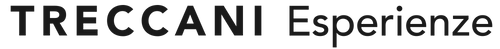L’impatto della collezione d’arte contemporanea di Peggy Guggenheim sulla Biennale di Venezia del 1948 fu notevole e non coinvolse solo gli esperti e gli addetti ai lavori. Da un lato, fu sancita l’affermazione di Guggenheim come personalità in grado di canalizzare e valorizzare energie e talenti; dall’altro, il pubblico europeo ebbe l’occasione di conoscere artisti americani che stavano sperimentando nuove strade. Un effetto ancora più grande lo ebbe sul pubblico italiano, che aveva vissuto decenni di relativo isolamento e di pressioni censorie, e non era entrato in contatto con le correnti più innovative.
Questo fecondo incontro maturò in un contesto particolare. In primo luogo, Peggy Guggenheim aveva già deciso di tornare in Europa, da cui si era allontanata a causa della guerra e delle persecuzioni razziali. Dopo la chiusura della galleria Art of this Century di New York nel 1947, la scelta di stabilirsi a Venezia fu per lei quasi inevitabile, era il riannodarsi di un legame già profondo, come ebbe a dire nelle sue memorie: «Si è sempre dato per scontato che Venezia è la città ideale per una luna di miele, ma è un grave errore. Vivere a Venezia o semplicemente visitarla significa innamorarsene e nel cuore non resta più posto per altro».
La seconda circostanza ha connotati ben più drammatici: mentre si stava preparando la XXIV Biennale, prevista per l’estate del 1948, la Grecia era dilaniata dalla guerra civile, che segnò il primo drammatico sviluppo, purtroppo caldo, cioè armato, di quella guerra fredda che si stava delineando a livello globale. Di fronte all’impossibilità della Grecia di partecipare, il segretario generale della Biennale Rodolfo Pallucchini decise di proporre a Guggenheim di portare la sua ricca e prestigiosa collezione privata alla Biennale, ospitandola proprio nel padiglione greco. Il coinvolgimento di Peggy Guggenheim avvenne su suggerimento dall’artista Giuseppe Santomaso, pittore di ricerca che attraversava in quel momento l’esperienza postcubista ed era membro del Fronte nuovo delle Arti, insieme a Renato Guttuso, Sante Monachesi, Giulio Turcato e altri che saranno anche essi presenti in quella storica Biennale.
Era il periodo dello scontro fra astrattismo e figurativismo, delle polemiche serrate sul ruolo dell’intellettuale a cui partecipava, spesso con veemenza, Roderigo di Castiglia, pseudonimo di Palmiro Togliatti, che su Rinascita attaccava la Prima mostra nazionale di arte contemporanea di Bologna, definendola «raccolta di cose mostruose». In questo clima aspro, ma finalmente vivo e partecipato, si innestò l’irruzione della collezione Guggenheim nella Biennale: erano presenti per la prima volta in Europa artisti come Jackson Pollock, William Baziotes, Mark Rothko e Clyfford Still, che erano stati concretamente sostenuti e incoraggiati da Peggy Guggenheim fin dai difficili esordi negli Stati Uniti. La mostra offriva una ricca panoramica dell’arte contemporanea, con il Cubismo, il Futurismo, il Surrealismo e la nuova tendenza dell’Espressionismo astratto che si stava affermando negli Stati Uniti. A fianco dei nuovi artisti americani, erano presenti molti artisti italiani come Giacomo Balla, Gino Severini, Giorgio de Chirico e Massimo Campigli, esponenti dell’arte astratta e surrealista, come Alberto Giacometti, Jean Arp, Costantin Brâncuşi. Furono esposte in tutto 136 opere, alcune delle quali furono in seguito donate a diversi musei nel mondo.
Il padiglione fu progettato da Carlo Scarpa, «l’architetto più moderno di Venezia» come ebbe a definirlo la stessa Peggy Guggenheim e fu molto apprezzato per il gusto e l’originalità. Le opere furono accostate seguendo relazioni e affinità formali, suggerite dai numerosi particolari geometrici. All’ingresso i visitatori erano accolti da un cartello disegnato da Scarpa che riportava la scritta «Collezione Peggy Guggenheim»: collocando le sue opere accanto agli altri padiglioni che avevano carattere nazionale, ed erano quindi denominati Gran Bretagna, Francia, Olanda, e così via, Guggenheim si sentì con orgoglio e ironia come «un nuovo Paese europeo».
L'esposizione riscosse un enorme successo, diventando una delle più apprezzate di quella edizione, peraltro molto ricca e interessante e soprattutto la prima dopo l’interruzione dovuta alla guerra. Il padiglione fu visitato dal presidente della Repubblica Luigi Einaudi e da grandi critici, tra cui Lionello Venturi e Bernard Berenson. La fotografa Lee Miller su Vogue definì il padiglione «il più sensazionale» della Biennale. L’effetto dirompente fu prodotto soprattutto dalla qualità dei pezzi, dall’originalità dell’allestimento, dal generoso impegno di Guggenheim. Ma contribuì senz’altro lo spirito dell’epoca, che nonostante le contraddizioni e le difficoltà del momento storico sembrava aprirsi al futuro con speranza di rinnovamento, nell’arte e nella vita. Un sentimento che traspare dalle parole di Vittorio Carrain, allora segretario della Collezione Peggy Guggenheim: «La Biennale del 1948 fu come stappare una bottiglia di champagne. Un’esplosione d’arte moderna dopo il tentativo del nazismo di ucciderla».