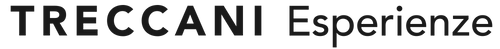È un immenso patrimonio quello che ci ha lasciato Gianni Berengo Gardin, morto a Genova il 6 agosto scorso, all’età di quasi 95 anni: un tesoro fatto non soltanto di immagini, ma anche di riflessioni su ciò che la fotografia può rappresentare.
Aveva iniziato il suo percorso nel 1954 pubblicando le sue foto sul Mondo di Mario Panunzio, una rivista che poneva grande attenzione alla qualità fotografica, dando spazio a geniali esordienti accanto a fotografi affermati a livello internazionale come Robert Capa o Henri Cartier-Bresson. Ma il fotogiornalismo dopo un po’ gli era apparso una dimensione troppo ristretta per i contenuti che voleva esprimere.
Il primo libro di Berengo Gardin è su Venezia, con cui aveva un legame fortissimo e duraturo; si tratta di Venise des Saisons, che esce nel 1965 per la casa editrice svizzera La Guide du Livre, dopo essere stato rifiutato da otto editori italiani. I testi che accompagnavano le immagini erano di Giorgio Bassani e Mario Soldati, che avevano subito riconosciuto lo straordinario talento del fotografo.
Dopo questi esordi non si è più fermato: Berengo Gardin ha pubblicato oltre 250 libri fotografici, ha esposto in più di duecento mostre in gallerie e musei in tutto il mondo, e le sue immagini sono conservate in molti importanti archivi.
Una carriera durata settanta anni, che ha attraversato ambiti e sensibilità diverse ma con una coerenza di fondo: la sua Leica, il bianco e nero, la centralità delle persone, l’aderenza alla realtà, la sensibilità sociale. Sosteneva: «La macchina fotografica è come la penna per lo scrittore: uno strumento per raccontare cose». Coerentemente, non considerava la pittura la forma d’espressione più vicina alla fotografia, ma piuttosto l’avvicinava alla letteratura, alla capacità di trasmettere storie. Rifiutava la definizione di artista: «Una foto non è bella, semmai è buona. La cosa più importante nel mio lavoro è stata acquisire la capacità di guardarmi intorno. Di guardare il reale. Se si è veramente fotografi si scatta sempre, anche senza rullino, anche senza macchina». Amava definirsi piuttosto un artigiano che cerca di fare il suo lavoro nel miglior modo possibile. Andava in giro e per strada coglieva l’istante, senza crearlo artificialmente e senza aspettarlo: voleva cogliere l’intera scena, in generale, con un focale di 33 millimetri, per restituire l’ambiente insieme ai personaggi, lo sfondo e l’azione.
La vocazione alla fotografia sociale lo ha reso protagonista di alcune importanti battaglie. Mentre Franco Basaglia sperimentava sul campo una nuova concezione della cura del disagio mentale, Berengo Gardin e Carla Cerati realizzavano i primi reportage nei manicomi: «Decisi di non fotografare la malattia, ma le condizioni della detenzione. Erano pratiche già proibite per legge, ma tutti se ne fregavano. La nostra denuncia fu importante». Da quelle foto, e dalla collaborazione con Basaglia, nacque il libro Morire di classe, che diede un importante contributo alla battaglia per l’approvazione della legge 180.
Un paese venti anni dopo è un’operazione di straordinario interesse: nel 1955 era uscito per Einaudi Un paese, libro di foto di Paul Strand con testi di Cesare Zavattini, dedicato alla realtà di Luzzara, un piccolo centro in provincia di Reggio Emilia. Einaudi pensò di ripetere l’operazione dopo venti anni per registrare i cambiamenti che erano incorsi in quel periodo: Strand per ragioni di età e salute si ritirò e Zavattini entrò in contatto con Berengo Gardin. Nel nuovo libro, che uscì nel 1976, il testo assumeva un rilievo maggiore, e le fotografie accompagnavano e ampliavano il discorso, evidenziando le trasformazioni in corso. Importante fu anche La disperata allegria. Vivere da Zingari a Firenze con prefazione di Günter Grass del 1994. Berengo Gardin trascorse diversi mesi nel campo nomadi di Firenze, cercando di coglierne il modo di vivere, i costumi, la musica, le difficoltà e, nello stesso tempo, mettendo anche a fuoco i pregiudizi e l’ostilità che li circondavano. Un’attenzione che continuò nel tempo e portò alla realizzazione nel 1997 di Zingari a Palermo.
Risale invece al 2014 il lavoro sulle grandi navi a Venezia: una serie di immagini realizzate che hanno documentato l’impatto sul paesaggio e sulla vita cittadina dal passaggio di questi invadenti colossi del turismo di massa.
Attraverso un lungo percorso, Gianni Berengo Gardin ha raccontato con “buone” fotografie la nostra vita e la nostra storia, il mondo in cui viviamo, inquadrando anche i lati che sembravano fuori fuoco; e un poco ha contribuito anche a migliorarlo.
Esplora anche tu ciò che ti circonda con la macchina fotografica: scopri la collana Oltre l’obiettivo.
Crediti della foto
Gianni Berengo Gardin, © CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons