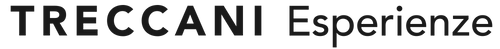Il carattere urbanistico e architettonico straordinario di Noto scaturisce da un evento tragico: il terremoto dell’11 gennaio 1693, che causò la morte di circa mille persone e la distruzione dell’antica città. Per motivi di sicurezza, si decise di spostare l’abitato in un altro sito, otto chilometri più a valle, sul declivio del colle Meti. Si trattò dunque della vera e propria costruzione di una città nuova, con le caratteristiche tardo-barocche che l’hanno resa celebre in tutto il mondo.
Noto Antica, collocata sul Monte Alveira, è un’area tuttora visitabile, dove sono rintracciabili i segni della storia della città prima del terremoto: un impianto medievale, con tratti delle mura di cinta e rilevanti edifici come il Castello Reale e l’Eremo di Santa Maria della Provvidenza.
La nuova Noto, invece, venne costruita secondo un progetto unitario che non doveva tenere conto di precedenti stratificazioni. Infatti, essa si presenta come una totalità organica, coerente nella sua impronta tardo-barocca e arricchita da qualche inserimento neoclassico. L’assetto urbanistico, disegnato dall'architetto Angelo Italia, ha un impianto rigorosamente geometrico ispirato ai canoni antichi. L'area dell'aristocrazia, delle istituzioni e della Chiesa - con gli edifici nobiliari e i complessi religiosi - si sviluppa nella parte bassa, sul pendio del colle Meti, ed è attraversata dai principali assi viari: corso Vittorio Emanuele, via Cavour e via Ducezio.
La parte popolare invece è stata costruita, con maglia a scacchiera, sulla spianata alta del colle. Venne impiegata ovunque la tenera pietra locale che, con i suoi toni rosati e dorati, conferisce alle architetture un senso di eleganza e di uniformità e assume diverse e affascinanti sfumature durante la giornata. Nei lavori vennero coinvolti numerosi e prestigiosi ingegneri e architetti, tra i quali ricordiamo Rosario Gagliardi, Paolo Labisi, Vincenzo Sinatra, Antonio Mazza. La tipologia architettonica più diffusa per i palazzi nobiliari è la struttura a corte centrale, spesso arricchita da giardini e fontane e intorno alla quale si strutturano i diversi ambienti, di solito articolati in due livelli sfarzosamente allestiti.
L’elemento più caratteristico però sono proprio i balconi: splendide sirene, grifoni alati, aquile e mostri sorreggono i mensoloni su cui poggiano, accanto a maschere grottesche e a un tripudio di motivi floreali e fogliati. Uno straordinario bestiario-erbario onirico a cielo aperto, frutto dell’abilità e dell’inventiva degli scalpellini siciliani che, durante tutto il Settecento, scatenarono la loro fantasia di ispirazione barocca decorando riccamente balconi e finestre con motivi floreali e conchiglie.
La presenza di numerose aperture nel prospetto degli edifici è una caratteristica peculiare dell’architettura residenziale netina ed è certamente legata al clima della città, molto caldo durante l’estate e mite d’inverno. Ma, al di là delle considerazioni pratiche, è proprio attraverso finestre e balconi che le famiglie aristocratiche facevano sfoggio della loro ricchezza e della loro raffinatezza e sottolineavano il proprio status. In tal senso, Palazzo Rau della Ferla e Palazzo Trigona di Cannicarao spiccano senz’altro tra gli edifici più rappresentativi, ma è il Palazzo Nicolaci - residenza urbana dei principi di Villadorata - a presentare un repertorio iconografico e decorativo particolarmente articolato.
La costruzione fu iniziata dal barone Corrado Nicolaci, che aveva acquisito i terreni, ma il progetto fu poi ampliato e trasformato dal figlio Giacomo e concluso nel 1765. Intellettuale ed erudito dai molti interessi, matematico e appassionato di storia, geografia, ottica, filosofia, arte e architettura, Giacomo conosceva varie lingue, aveva viaggiato a lungo in Europa e raccolto suggestioni e volle imprimere all’edificio un’impronta molto particolare, modulando le proprie intuizioni con l’operato di architetti locali. La facciata è uno degli elementi più significativi del linguaggio architettonico del tardo-barocco, non solo della città ma di tutta la Valle di Noto. I suoi balconi si presentano con ringhiere bombate in ferro battuto e sono sorretti da mensole scolpite con creature grottesche e mitologiche, motivi floreali e fogliati. Sono stati fatti molti tentativi per interpretare le figure che popolano la base dei balconi, dai leoni ai centauri, dai puttini ai cavalli alati, dalle chimere e alle sirene, accanto a riferimenti a episodi biblici. Ne è stata proposta una lettura in chiave scaramantica, riprendendo credenze popolari, secondo cui sarebbero entità apotropaiche per tenere lontano la sfortuna e il malocchio. Tuttavia, Giacomo era anche interessato all’ermetismo, alle scienze occulte e all’alchimia e, in questa chiave, le diverse creature potrebbero rappresentare tappe del cammino verso la conoscenza. Qualunque sia stata l’idea originaria, di certo esse mantengono ancora un potere quasi ‘magico’, capace di farci tenere lo sguardo costantemente rivolto verso l’alto.
Crediti della foto
Dettaglio dei telamoni che decorano un balcone a Noto, Sicilia.