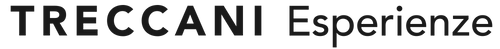La nocciola rappresenta un patrimonio importante delle colline piemontesi e delle Langhe in particolare, nota a livello globale per la sua qualità superiore. La denominazione IGP è riservata alla cultivar “Tonda Gentile Trilobata” quando sia prodotta in un territorio idoneo della regione Piemonte. Dal 2018, è possibile aggiungere al prodotto la denominazione “Langhe” solo se proviene effettivamente da quella specifica area, un’attenzione che testimonia la difesa convinta della qualità del prodotto e il forte legame che esiste fra la nocciola e questo territorio.
Il nocciolo (Corylus avellana), originario dell’Asia, si diffuse già in epoche lontane in tutta l’area del Mediterraneo, in particolare in Italia, Francia, Spagna e Turchia. Ha assunto nelle diverse culture un carattere simbolico importante, a volte addirittura sacro, ad esempio fra i popoli celti, e nell’antica Roma le sue foglie e i suoi rami venivano regalati come augurio di felicità; già allora, il gusto delle nocciole era molto apprezzato e il loro consumo diffuso.
La coltivazione della nocciola in Piemonte ha origini remote ma si affermò gradualmente: fino al Medioevo le nocciole venivano prevalentemente raccolte nei boschi e non erano commercializzate ma destinate a un consumo diretto. Tra il XVIII e il XIX secolo, la nocciola piemontese iniziò a farsi conoscere al di fuori dei confini regionali, grazie alla sua qualità superiore, assumendo così un rilievo economico più importante. È in questo periodo che la sua storia si intreccia con quella di un altro prodotto d’eccellenza piemontese, il cioccolato: un’alleanza duratura e dagli esiti deliziosi.
Sulla diffusione del consumo e della produzione del cioccolato in Piemonte esistono diverse ricostruzioni e alcune leggende. Una delle più note vuole che nel 1560 per festeggiare il trasferimento della capitale da Chambéry a Torino, il duca Emanuele Filiberto di Savoia abbia offerto simbolicamente alla città una tazza di cioccolata bollente. Storia affascinante, ma priva di solidi riscontri, anche perché il duca entrò a Torino soltanto dopo il ritiro delle truppe francesi, alla fine del 1562. Inoltre, diversi storici dell’alimentazione concordano nel sostenere che un carico di chicchi di cacao in partenza da Veracruz arrivò a Siviglia solo nel 1585, portando così per la prima volta il prodotto in Europa; il duca Emanuele Filiberto era morto da cinque anni, di cirrosi epatica, dovuta, secondo i maligni, all’abitudine di bere bevande ben diverse dalla cioccolata, e cioè l’amato vino piemontese. Comunque, e su questo punto i riscontri sono numerosi, la cioccolata si diffuse ampiamente nel XVII e nel XVIII secolo, a Torino e nel Piemonte, soprattutto negli ambienti nobiliari e nella stessa Corte sabauda.
Anche l’incontro fra le due tradizioni, quella del cioccolato e quella della nocciola, destinate a un connubio fecondo che porterà alla nascita del gianduiotto, ha una storia particolare. La tradizione vuole che il gianduiotto sia nato come conseguenza del “blocco continentale” imposto da Napoleone nel 1806, che vietava il commercio tra i Paesi sotto controllo francese e il Regno Unito, coinvolgendo anche i prodotti coloniali. Molti storici concordano sul fatto che quella guerra commerciale fu estremamente dannosa, soprattutto per la Francia: il cacao diventò difficilmente reperibile e di conseguenza molto caro. Una situazione che spinse molti cioccolatai piemontesi a immettere nell’impasto una buona quantità di nocciole, che erano invece un prodotto tipico delle colline locali e quindi abbastanza a buon mercato. È credibile che i produttori di cioccolato siano ricorsi a questo, peraltro squisito, espediente: però l’immissione nel mercato del gianduiotto avvenne comunque alcuni decenni dopo la fine del blocco.
Nei primi decenni dell’Ottocento, molti cioccolatieri utilizzavano le nocciole tritate nell’impasto: nasce così dal loro ingegno il givu (mozzicone), l’antenato del gianduiotto. L'esordio vero e proprio del gianduiotto avvenne durante il Carnevale del 1865, quando fu distribuito per le strade di Torino da una persona nelle vesti della tipica maschera piemontese, Gianduia; da allora in poi i nuovi cioccolatini furono chiamati gianduiotti. È interessante notare che Gianduia è, nella tradizione, un buon bevitore di vino rosso: la sua figura racchiude quindi alcuni ‘pilastri’ dell’enogastronomia piemontese: le nocciole, il cioccolato, il vino.
Nel solco dell’incontro fra nocciole e cacao, va inserita anche la Nutella, la mitica crema inventata dalla Ferrero nel 1964 e diventata nel tempo la crema spalmabile più venduta al mondo. La base di partenza era il Giandujot, una pasta dolce a forma di panetto, che poteva essere affettata e spalmata sul pane: un prodotto che ancora una volta nasceva dall’esigenza di ‘rimpolpare’ l’impasto con le nocciole per via della scarsa reperibilità di cacao durante i difficili anni della guerra e dell’immediato dopoguerra.
Con alle spalle questo patrimonio di esperienze e tradizioni, la nocciola piemontese continua il suo viaggio, senza conoscere crisi ma anzi sviluppandosi con il più vasto e vario impiego nella produzione dolciaria.
Una storia gentile tutta da approfondire con Tesori d’Alta Langa.