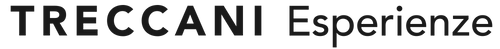Lieto del vento, distese le vele Odisseo luminoso.
Così col timone drizzava il cammino sapientemente,
seduto: mai sonno sugli occhi cadeva,
fissi alle Pleiadi, fissi a Boòte che tardi tramonta,
e a all’Orsa, che chiamano pure col nome di Carro,
e sempre si gira e Orione guarda paurosa,
e sola non ha parte ai lavacri d’Oceano;
quella infatti gli aveva ordinato Calipso, la dea luminosa,
di tenere a sinistra nel traversare il mare.
Odissea, V, 268-277
Eppure, per molto tempo l’umanità ha avuto il problema opposto: orientarsi nei propri spostamenti e raggiungere determinati luoghi senza sbagliare strada, senza scomparire per sempre nell’ignoto. Le difficoltà più grandi le affrontava chi viaggiava in mare e solo dopo secoli di tentativi, attenta osservazione, metodi empirici, calcoli e lo sviluppo di strumenti via via più efficaci, è divenuto più semplice per marinai ed esploratori mantenere la rotta, raggiungere mete lontane e riuscire a tornare a casa, magari dopo aver attraversato oceani e terre sconosciute.
Nel mondo antico si preferiva rimanere vicino alla riva e utilizzare le caratteristiche visibili della terraferma per determinare la propria posizione; era una navigazione che si potrebbe definire di cabotaggio, fatta di viaggi brevi e con la costa a vista: il mare aperto era vissuto con timore, anche se a volte era necessario affrontarlo. Un grande aiuto nell’orientamento però veniva anche dall’osservazione del cielo, con i corpi celesti a fare da guida.
Infatti, i riferimenti fondamentali erano il Sole durante il giorno e, per gli abitanti dell’emisfero boreale, la Stella Polare di notte. Di giorno, la posizione del Sole permetteva di individuare i punti cardinali e la latitudine; mentre, di notte, la Stella Polare consentiva di stabilire la collocazione del Nord e di osservare il movimento delle costellazioni avendo quest’ultimo come punto fermo.
I Fenici erano navigatori esperti e osavano allontanarsi dalla rassicurante vista della costa, orientandosi attraverso le costellazioni circumpolari, che restano sopra l'orizzonte per tutta la notte, e concentrando la loro attenzione sulle due Orse, in particolare su quella Minore. Furono loro i pionieri dell’astronomia nautica, tanto che - grazie alle loro competenze - superarono le colonne d’Ercole, esplorando verso Nord la Gran Bretagna e verso Sud le coste dell’Africa.
I Greci furono profondamente influenzati dalle tecniche sperimentate dai Fenici e alcune fonti suggeriscono che come loro fossero soliti tenere lo sguardo puntato soprattutto sull’Orsa Minore. Ma, nella cultura greca, tracce di astronomia nautica si scorgono anche nei grandi capolavori letterari, come l’Odissea. Ad esempio, quando la ninfa Calipso accetta a malincuore di far partire Odisseo, per obbedire al volere degli dèi «invidiosi e maligni», suggerisce all’amato eroe la rotta per raggiungere Itaca: un percorso che va da Sud-Ovest a Nord-Est, lungo il quale per orientarsi basta tenere l’Orsa Maggiore sulla sinistra e la costellazione di Boote e le Pleiadi sulla destra.
Anche i Romani seguirono la scia dei loro predecessori, come ci testimonia Marco Anneo Lucano nel poema epico Bellum civile, detto la Farsaglia, raccontando che Pompeo, dopo la sconfitta di Farsalo, navigava verso la Sirte orientandosi con le due Orse.
I metodi impiegati dagli antichi, sebbene all’avanguardia per il tempo, erano limitati in modo significativo dalle condizioni atmosferiche, risultando adatti ad essere utilizzati soprattutto durante la bella stagione. Soltanto nel Medioevo ci furono ulteriori e importanti progressi, mediante la creazione di innovativi strumenti fondati sul magnetismo, come la pisside nautica e la bussola.
L’utilizzo della bussola, di probabile origine cinese, si diffuse in Europa a partire dal XII secolo tramite gli arabi; anche se esiste un’altra ricostruzione, priva di solidi riscontri, che vuole che questa innovazione sia stata introdotta dall’amalfitano Flavio Gioia, figura leggendaria nata forse da un equivoco linguistico.
La bussola fornì un nuovo importante supporto, ma i naviganti continuarono a cercare aiuto nelle stelle, anche perché restava complicato misurare in modo accurato la longitudine: un problema con cui astronomi, cartografi ed esploratori si confrontarono per secoli.
I portoghesi, sollecitati dal principe Enrico il Navigatore (1394-1460), affrontarono grandi viaggi di esplorazione e studiarono con cura le variazioni dei venti. Inoltre, si dotarono di strumenti che, partendo sempre dalla posizione della Stella Polare e delle ultime stelle dell’Orsa Minore, le Guardas, consentivano di identificare la propria posizione con una certa precisione, a favore dei cartografi. Ciò nonostante, nel XVI secolo non vi era ancora uniformità di comportamenti fra i grandi navigatori e Cristoforo Colombo, ad esempio, affrontò l’Atlantico basandosi sulla tecnica dei punti stimati, cioè misurando ogni giorno le distanze percorse e il tempo impiegato. I suoi viaggi ebbero gli esiti che conosciamo, ma le sue misurazioni furono alquanto imprecise.
I regnanti di grandi potenze marittime, quali Spagna, Portogallo e Inghilterra, offrirono importanti premi in denaro a chi avesse fornito un metodo accurato per misurare la longitudine. Persino Galileo Galilei accettò la sfida, affidandosi alle eclissi dei quattro maggiori satelliti di Giove, da lui scoperti. Il progetto ambizioso prevedeva osservazioni astronomiche fatte direttamente sul ponte delle navi e confrontate con analoghi rilievi in terraferma, ma non ottenne i risultati sperati e non riuscì a intascare la grande ricompensa promessa dalla corona di Spagna. Anche i premi previsti dal governo inglese nel 1714 (Longitude rewards) si tradussero in somme parziali per risultati parziali. Solo nel XIX secolo, ci fu un effettivo salto in avanti, con il contributo di navigatori ricchi di ingegno e curiosità, come Thomas H. Sumner e Marcq Saint-Hilaire, che svilupparono il sistema delle rette di altezza, che permetteva di individuare la posizione esatta della nave, latitudine e longitudine, basandosi su almeno due misure di altezza e di tempo di un astro qualsiasi. Da quel momento in poi smarrirsi in mare diventò sempre più raro.
Ancora oggi, guardando un cielo stellato dal ponte di una nave, proviamo una forte emozione, schiacciati tra due immensità. Pur dotati di sofisticati dispositivi rimaniamo in bilico fra tornare a casa e cercare l’ignoto: intuiamo che il percorso che ci riporta a Itaca non è un semplice algoritmo.