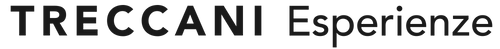L'innocente divertimento della campagna è divenuto a' dì nostri una passione, una manìa, un disordine. Virgilio, il Sannazzaro, e tanti altri panegiristi della vita campestre, hanno innamorato gli uomini dell'amena tranquillità del ritiro; ma l'ambizione ha penetrato nelle foreste: i villeggianti portano seco loro in campagna la pompa ed il tumulto delle città, ed hanno avvelenato il piacere dei villici e dei pastori, i quali dalla superbia de' loro padroni apprendono la loro miseria.
Carlo Goldoni, Le smanie della villeggiatura, L’autore a chi legge
Si è aperta una riflessione a livello internazionale sulle conseguenze del turismo di massa, che alcuni esperti iniziano a considerare addirittura un fenomeno in fase di estinzione, e quindi della durata complessiva di qualche decennio. Nel giro di pochi anni si è passati dalla preoccupazione per il crollo del turismo, a causa della pandemia, ai rischi dell’overtourism, cioè dell’eccessiva concentrazione di visitatori in alcune località, con conseguenze negative sull’ambiente e sulla qualità della vita sia delle popolazioni locali sia dei turisti stessi.
La vacanza, intesa come periodo di riposo, di svago e di fuga dal caldo estivo delle città, ha origini lontane, ma si è trattato a lungo di una possibilità riservata a ristrette minoranze privilegiate. Le ferie retribuite e il turismo di massa sono infatti fenomeni piuttosto recenti, novecenteschi, e hanno coinvolto nuovi continenti soltanto negli ultimi decenni. Nondimeno se si approfondisce lo sguardo, si scopre che una visione troppo lineare e meccanica del progresso non aiuta a comprendere la complessità dell’evoluzione storica.
Nell’antica Roma, durante l’estate, i patrizi si recavano nelle loro ville di campagna, sottraendosi agli impegni della vita quotidiana. Era il tempo dell’otium, che non era concepito come mera inattività ma piuttosto come possibilità di dedicarsi alla vita interiore, alla riflessione, alla cultura, in opposizione al negotium, il tempo alla vita pubblica. Naturalmente trattandosi di aristocratici anche il negotium era qualcosa di diverso dal lavoro in senso moderno: ci si riferiva piuttosto all’impegno nella politica, negli affari, nell’amministrazione delle terre e delle proprietà. Una situazione simile si ritrova nell’antica Grecia, dove era anche molto radicata l’abitudine di spostarsi per partecipare a eventi religiosi e sportivi. Pochi aristocratici si concedevano anche una sorta di turismo culturale verso l’Egitto. Quindi si viaggiava e ci si spostava, ma la stragrande maggioranza della popolazione era esclusa da questa possibilità.
La plebe romana restava in città d’estate e soprattutto continuava a lavorare anche durante le feriae previste dal nutrito calendario religioso. Con l’Impero, al fianco del culto degli dèi, si innescò progressivamente quello dell’imperatore: la grande operazione culturale di Augusto è stata quella di associare all’enorme cambiamento in corso, dalla Repubblica all’Impero, una ideologia conservatrice di ritorno ai valori del passato.
Agosto, come venne rinominato il mese sextilis in onore dell’imperatore, era puntellato di giorni festivi che da un lato riprendevano la tradizione contadina del riposo tra le fatiche del raccolto appena terminate e quelle imminenti della vendemmia, dall’altro celebravano la conquista di Alessandria (1° agosto 30 a. C.) con la sconfitta di Antonio e di Cleopatra e il trionfo di Ottaviano. Durante le cosiddette Feriae Augusti, il nome con cui venivano comunemente chiamate queste celebrazioni, si inaugurava un periodo dell’anno contrassegnato da varie cerimonie religiose, banchetti e corse di cavalli.
Nel mondo antico per i plebei, e naturalmente per gli schiavi, non era neanche presa in considerazione l’idea di avere diritto a ferie retribuite, e questa situazione non cambia nel Medioevo. A tal proposito, ha però suscitato interesse alcuni anni fa il saggio di Juliet B. Score, L'americano oberato di lavoro: l'inaspettato declino del tempo libero, in cui si sosteneva la tesi, in apparenza paradossale, che un contadino medioevale lavorava di meno di un operaio, di un impiegato o di un libero professionista dei giorni nostri. Secondo alcuni studi la giornata lavorativa medievale non superava in generale le otto ore e il calendario era fitto di ricorrenze religiose durante le quali le attività produttive erano sospese. Inoltre, il lavoro agricolo era di per sé discontinuo, cessava di necessità al tramonto e nell’inverno era piuttosto ridotto. C’era dunque molta povertà e un grande dispendio di fatica fisica, ma senza orari eccessivi. Nei castelli e nelle corti la vita era ben diversa. In seguito, durante il Rinascimento, si assistette a un ritorno, per le famiglie aristocratiche e dei ricchi mercanti, all’abitudine di soggiornare nelle ville di campagna in determinati periodi dell’anno; si trattava in alcuni casi di residenze splendide, che esprimevano e rendevano visibili i valori di un’intera epoca.
Con la rivoluzione industriale le cose cambiarono e l’orario di lavoro si allungò notevolmente. Al tempo stesso, la villeggiatura non era più soltanto un privilegio degli aristocratici: i mercanti e i ricchi borghesi volevano imitarli, per questioni principalmente di prestigio, e la loro smania della villeggiatura venne bonariamente presa in giro da Carlo Goldoni. Il non saper stare al loro posto ed essere sine nobilitate li rendeva ridicoli. Nel XVIII secolo si diffuse anche la moda del Grand Tour, il viaggio di formazione dei giovani dell’aristocrazia europea, che aveva come destinazione preferita proprio l’Italia, con il suo patrimonio naturale, archeologico e artistico e che in qualche modo rappresentò un momento di avvio del turismo moderno e di quello culturale in particolar modo. Soltanto con il Novecento venne riconosciuto e si diffuse il diritto alle ferie pagate, che è uno degli elementi che ha contribuito allo sviluppo del fenomeno del turismo di massa. In Francia, il governo del Fronte Popolare riconobbe nel 1936 il diritto a quindici giorni di ferie pagate per tutti i lavoratori. Nell’Italia fascista la Carta del lavoro varata il 21 aprile del 1927 sanciva il diritto «dopo un anno di ininterrotto servizio» a un periodo di «riposo feriale retribuito». Nella realtà i periodi effettivi di ferie erano molto brevi, ma si trattava comunque di un passo in avanti. La Costituzione Italiana entrata in vigore nel 1948 sancì in modo irreversibile il diritto irrinunciabile del lavoratore a ferie annuali retribuite: il lavoratore deve prendere obbligatoriamente le ferie che gli spettano.
Analoghi provvedimenti si diffusero in Europa soprattutto nel secondo dopoguerra. Le ferie pagate non significano necessariamente vacanza, ma dal boom economico in poi molte famiglie italiane (non tutte però) iniziano a concedersi periodi di villeggiatura, principalmente in località marine. Con la globalizzazione sono entrati nel circuito turistico mondiale nuove realtà e nuovi popoli, sia come mete turistiche sia come viaggiatori, con importanti ricadute economiche e qualche disagio. Nel godersi il riposo e la vacanza è importante ricordare però il lungo percorso che ha portato fasce ampie della popolazione ad esercitare quello che, nonostante tutto, rimane un prezioso diritto.
Quale sarà la meta della tua prossima vacanza? Scopri le Esperienze.
Crediti della foto
Évariste Carpentier, In villeggiatura, 1890-95, Museo Fabre, via Wikimedia Commons