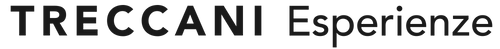La neve si seppellisce viva, perché viva si conservi e ingentilisca l’estate.
Simonide (VI-V sec. a.C.)
Porterassi neve distante ne’ lochi caldi, tolta dall’alte cime de’ monti, e si lascierà cadere nelle feste, alle piazze, nel tempo dell’estate.
Leonardo da Vinci
Il gelato ha una storia antica alle spalle, anche se per secoli si è trattato di un consumo raro ed elitario, a causa delle difficoltà di realizzazione e dei costi. Già nell’antica Cina è documentato il consumo di dolci solidi e freddi, prepararti con neve, latte, riso e spezie; mentre Greci e Romani avevano sviluppato dei sistemi per la conservazione della neve, impiegata per ottenere bevande fresche e qualcosa di simile agli attuali sorbetti con l’aggiunta di miele e frutta. Abitudini e competenze queste che per alcuni secoli furono forse accantonate: nel corso dei primi secoli del Medioevo non ci sono tracce di preparazioni simili in Europa.
I sorbetti vennero reintrodotti in Occidente nel corso del IX secolo grazie alla presenza degli Arabi in Sicilia e preparati con la neve dell’Etna e succhi di frutta. Non a caso la loro denominazione nasce probabilmente dal turco şerbet e dall’arabo sharba «bibita fresca», poi accostati a sorbire. I punti di contatto con il moderno gelato artigianale ci sono, ma si trattava comunque di un prodotto diverso, riservato alle classi privilegiate. Infatti, nel Basso Medioevo e nel Rinascimento, quest’ultimo si diffuse molto lentamente in Europa e soltanto nelle corti e tra l’aristocrazia.
La storia, però, prosegue e ci porta nella Firenze dei Medici, dove i sorbetti erano ormai ben conosciuti. Si dice che persino Leonardo da Vinci potrebbe aver fatto riferimento alla loro preparazione in una sua metafora sulle fontane: «Porterassi neve distante ne’ lochi caldi, tolta dall’alte cime de’ monti».
Secondo la leggenda, al momento del matrimonio tra Caterina de’ Medici ed Enrico II di Francia, Caterina portò con sé il pasticcere Ruggeri, che aveva già lavorato presso la corte fiorentina. Durante il banchetto nuziale del 1533, Ruggeri avrebbe servito i suoi dolcetti gelati, così deliziosi da ottenere un successo straordinario presso la corte francese: un successo tanto grande da suscitare invidie e maldicenze tali da convincerlo, poco dopo, a fare ritorno in Italia.
La vicenda suggerisce come la famiglia Medici abbia avuto un ruolo fondamentale nel far conoscere le potenzialità dei raffinati sorbetti alla corte di Francia; ma fu proprio nella loro Firenze che venne sperimentato e diffuso un prodotto che comprendeva l’utilizzo del tuorlo d’uovo e del latte vaccino, preludio del gelato odierno. Tale novità venne proposta da Bernardo Buontalenti (architetto, scultore e pittore) in occasione di una visita di ambasciatori spagnoli alla corte dei Medici, nel 1565. Buontalenti riuscì nello scopo di stupire i prestigiosi ospiti creando un gelato a base di neve, sale, latte, miele, tuorlo d’uovo e vino, che viene ancora oggi offerto, con poche varianti, nelle gelaterie locali con il nome di crema fiorentina.
Nei secoli successivi il gelato iniziò a entrare gradualmente nel consumo di massa, grazie al contributo di altre personalità e di ulteriori innovazioni: in particolare, nel 1686, il siciliano Francesco Procopio inaugurò a Parigi il Café Procope, la prima gelateria della storia, peraltro ancora esistente. Procopio propose molte varianti a base di frutta e di spezie, ma una delle specialità più apprezzate era il gelato al caffè, una novità assoluta. Poi, nel XVIII secolo, avvenne il passaggio dall’utilizzo diretto della neve come ingrediente base al suo uso per ottenere il raffreddamento del composto da servire. Traccia di questo cambiamento, che completa l’evoluzione degli antichi sorbetti verso il gelato moderno, si trova nel 1778 nell’opera Il credenziere di buon gusto del cuoco napoletano Vincenzo Corrado.
Nel 1843 una straordinaria invenzione rese più agevole la produzione del gelato: il mantecatore a manovella, creato e brevettato a Philadelphia da Nancy Johnson. Il successo fu enorme, ma l’inventrice se ne avvantaggiò relativamente; pochi anni dopo, trovandosi in difficoltà economiche, fu costretta a vendere il brevetto per soli duecento dollari. Grazie a questa innovazione, fu più semplice produrre gelato e anche variare i gusti.
La nascita del cono, invece, è successiva al diffondersi del gelato in Europa e negli Stati Uniti d’America. Si racconta che il cono sia nato negli Stati Uniti da un incontro casuale, alla Fiera mondiale di St. Louis nel 1904: il pasticcere Ernest Hamwi, con il suo stand di wafer, era accanto a una gelateria che aveva esaurito i piatti su cui offriva il prodotto ai clienti. Hamwi, vedendo il gelataio in difficoltà, ebbe l’idea di arrotolare uno dei suoi wafer intorno a un tubo di metallo a forma di cono affinché nel vicino stand potessero continuare a servire il gelato. A rivendicare l’invenzione, però, c’è anche il gelataio di origine veneta Italo Marchioni, attivo a New York, che, secondo fonti locali, propose i coni fin dal 1896 e progettò in seguito anche le macchine per produrli in serie. Sono passati, dunque, più di cento anni, in cui abbiamo potuto affrontare il calore dell’estate allietati da gelati artigianali serviti su coni croccanti.
Nel secondo dopoguerra iniziò a diffondersi anche in Italia il gelato industriale, già presente da parecchi decenni negli Stati Uniti: una realtà che ha il suo spazio, ma non ha intaccato il prestigio e la diffusione del gelato artigianale che - a livello globale - rimane comunque un simbolo delle tradizioni italiane.
Il gelato ci parla di contaminazioni tra gusti, ingredienti e popoli. Come la cassata, i cannoli, la pasta reale e i dolci alla cannella, in Sicilia, è erede di una tradizione culinaria fiorita anche grazie alla presenza araba. Sopri la Sicilia autentica partendo dal gusto, con Quintessenza di Sicilia.
Foto
Gregory Peck e Audrey Hepburn, scena dal film Vacanze romane, 1953, di William Wyler.