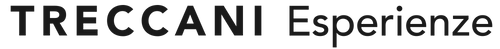Esponente dell’arte informale e protagonista di una ricerca che si rinnovava costantemente, Alberto Burri è da tempo riconosciuto come uno degli artisti italiani più importanti della seconda metà del Novecento. Eppure, nei suoi primi anni di attività furono numerose le critiche, aspre e a volte sarcastiche, e fu largamente diffuso un atteggiamento teso a ridimensionare il suo il valore. Attacchi questi a cui Burri non rispose mai, rifiutandosi di difendere o soltanto commentare le sue stesse opere, nella convinzione che parlassero da sole: «Le parole non mi sono d’aiuto quando provo a parlare della mia pittura. Questa è una irriducibile presenza che rifiuta di essere tradotta in qualsiasi altra forma di espressione».
Tra i tanti, un episodio in particolare rimane emblematico, poiché colpì l’artista quando aveva già ottenuto i primi importanti riconoscimenti e soprattutto perché coinvolse non solo la critica, ma anche gli intellettuali e la politica. Nel 1959 Palma Bucarelli, prima donna italiana alla guida di un museo, allora direttrice della Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma, decise di esporre alcune opere di Burri, fra cui Grande sacco, realizzato nel 1952 e parte della celebre serie dei Sacchi, che l’artista stava portando avanti in quegli anni. Una scelta che generò un immediato scandalo, venendo fortemente contestata da chi considerava l’opera incomprensibile al grande pubblico e non rappresentativa delle tendenze significative dell’arte italiana in quel periodo.
Il 10 aprile 1959 il vicepresidente del Senato, Ettore Tibaldi, lesse in aula un’interrogazione parlamentare, presentata dal senatore comunista Umberto Terracini, che chiedeva spiegazioni sulla cifra spesa per l’acquisto di un’opera definita una «vecchia, sporca tela sdrucita da imballaggio che, sotto il titolo di Grande sacco, è stata messa in cornice da tal Alberto Burri». Angelo Di Rocco, sottosegretario alla Pubblica Istruzione, nel rispondere all’interrogazione precisò che il quadro non era stato acquistato, ma si trovava in deposito dopo essere stato esposto, qualche anno prima, in una mostra collettiva. La precisazione non fu sufficiente a mitigare le polemiche, poiché il tema dei costi veniva posto a partire da una completa svalorizzazione del contributo di Burri, indegno di essere esposto, anche se in forma gratuita, in una così prestigiosa sede. Per la parte politica, oltre a Terracini, pronunciò parole durissime anche il socialdemocratico Luigi Preti, che era stato fino al gennaio di quell’anno ministro delle Finanze: «Al bando gli artisti veri per far posto agli sgorbi, alle tele di sacco, ai buchi incorniciati e alle ferraglie».
Non c’è traccia per cui si possano collegare questi giudizi ai trascorsi di Burri, legato in gioventù al regime fascista; tutto fa pensare che la molla che fece scattare i giudizi fu proprio l’ostilità verso un certo tipo di ricerca creativa che si poneva al di fuori degli schemi consolidati.
Molti intellettuali partirono all’attacco proprio in occasione dell’esposizione del 1959. Marziano Bernardi su “La Stampa” affermò che la bellezza delle opere di Burri si poteva trovare presso un venditore di patate e aggiunse: «i pezzi di tela di sacco bucati, non entreranno nell’arte neppure tra mille anni, poiché sono solo buffonate». Parteciparono alla polemica anche persone comuni che scrissero lettere di protesta ai giornali, coinvolgendo ovviamente anche Palma Bucarelli, reputata responsabile e definita ‘signora degli stracci’ e sulla quale infierì anche Giorgio De Chirico, chiamandola «amazzone delle croste».
Non mancarono però anche voci a favore dell’artista: Emilio Vedova esaltò il contrasto tra l’uso di materiali poveri e deteriorati e l’eleganza formale con cui venivano riproposti sulla tela; Lara Vinca Masini mise in evidenza il significato esistenziale e collettivo delle opere; mentre per Giulio Carlo Argan l’arte di Burri era «una sorta di trompe-l’oeil a rovescio, nel quale non è la pittura a fingere la realtà ma la realtà a fingere la pittura».
Alcuni anni dopo queste polemiche, lo storico dell’arte Maurizio Calvesi scrisse parole che ci appaiono in qualche modo definitive: «Burri è riuscito, forse per l’ultima volta, a portare la vita nell’arte». Altri critici, come Emilio Villa, che pur valutarono importante la ricerca di Burri, riconobbero il disorientamento che le sue opere potevano suscitare, poiché in qualche modo si ponevano al di là della pittura, in un territorio diverso.
Per uno strano destino, fu proprio negli Stati Uniti – dove la sua esperienza artistica era iniziata quando, prigioniero in Texas durante la Seconda guerra mondiale, dipingeva il paesaggio oltre i reticolati – che Burri trovò presto riconoscimento. A promuoverlo fu James Johnson Sweeney, direttore del Guggenheim Museum di New York, che organizzò una mostra itinerante.
Riattraversando con gli occhi di oggi l’intera storia dell’artista e il vivo dibattito intorno al Grande Sacco, emerge chiara la lungimiranza di Palma Bucarelli e si coglie tutta la chiusura da parte della critica di fronte a nuove frontiere, a nuove sfide. Al tempo stesso, però, affiora un po’ di nostalgia per una società che si accendeva, si confrontava e si scontrava duramente sul ruolo dell’arte. Per una società che si esaltava o si scandalizzava dinanzi al messaggio che Burri stava mandando, ma che condivideva l’idea che l’arte dovesse avere un ruolo e che fosse importante discutere su cosa avesse diritto o no a stare in un museo, su cosa fosse davvero arte e cosa soltanto provocazione o mercato.
Crediti della foto
Interno di Palazzo Albizzini, courtesy of Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri.