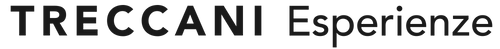Il tramonto della cravatta, spesso annunciato, non si è mai compiuto: se sono sempre meno i luoghi e le situazioni in cui la si deve indossare, questa icona di stile ha conquistato altri territori, luoghi e contesti in cui si vuole utilizzarla, spesso in modo più informale e creativo. Inoltre la cravatta, tradizionalmente percepita come un accessorio maschile, legato all’autorevolezza se non al potere, ha dimostrato una grande capacità di adattamento alle trasformazioni, attraversando anche i confini di genere e i codici formali. Come in molti altri casi, ha accompagnato l’evoluzione della società: le suffragette la utilizzavano come simbolo della lotta per la parità e i diritti delle donne, poi si è trasformata in un messaggio di autorevolezza misto all’eleganza, e a volte ha assunto anche carattere di trasgressione e di rivolta.
La cravatta attualmente viene considerata in modo molto diverso rispetto a quando veniva associata a conformismo, rispettabilità e formalità. Del resto, ha una lunga storia alle spalle e la sua connotazione, così come il suo ruolo simbolico, hanno subìto varie evoluzioni. Spesso il momento della nascita della cravatta viene associato alla presenza a Parigi di militari croati assoldati dalla Francia nel corso della Guerra dei Trent’anni. I loro foulard annodati avevano suscitato curiosità e interesse, fino a diventare una moda, rilanciata e amplificata da Luigi XIV, che iniziò a indossare una sorta di cravatta di pizzo, nel 1645, a soli sette anni. Il nome cravate sarebbe quindi una distorsione della parola hrvati, cioè “croati” in lingua croata.
Questa narrazione dell’origine della cravatta, per quanto affascinante e ampiamente diffusa, viene contestata da alcuni esperti di storia della moda. Il primo snodo di questa vicenda lo troviamo infatti nel libro Degli habiti antichi e moderni di diverse parti del mondo, di Cesare Vecellio (1530-1601), pubblicato nel 1590 a Venezia e corredato da numerose e notevoli illustrazioni. Tra i tanti capi di abbigliamento trattati c’è anche la cravatta, citata dunque molti decenni prima dell’arrivo dei croati a Parigi. Addirittura due secoli prima di Vecellio, modesto pittore ma tra i primi moderni a parlare di moda, il poeta francese Eustache Deschamps (1346-1406), grande misogino e prezioso testimone dei costumi della sua epoca, scrisse una ballata intitolata Faite restraindre sa cravate, ovvero “Riannodate la sua cravatta”. Queste tracce collocano in una diversa luce quantomeno l’origine del nome.
Peraltro, gli antenati della cravatta furono numerosi: una specie di bandana si vede al collo dei guerrieri dell’Esercito di terracotta di Xi´an e la straordinaria opera risale al III secolo a.C. Qualcosa di simile la indossavano anche i soldati romani: si tratta del focale, detto anche sudarium, una semplice sciarpa di lana o di lino che veniva annodata intorno al collo. Il focale viene citato in letteratura (Marziale, Orazio, Svetonio) e riprodotto in alcuni monumenti, come l’arco di Settimio Severo o la Colonna Traiana. In qualche modo, l’origine della cravatta è rintracciabile anche come variante delle antiche sciarpe, presenti persino nell’Egitto dei faraoni e in altre culture, con funzioni sia pratiche che decorative.
Nondimeno, se la vicenda dei soldati croati è forse un solo un pezzo di verità, rimane il fatto che la moda della cravatta esplose fra i nobili e la borghesia francese proprio durante la regale infanzia di Luigi XIV e si diffuse nelle diverse corti europee, sostituendo la rinascimentale gorgiera, utilizzata sia dalle donne sia dagli uomini dell’aristocrazia a partire dal XVI secolo. Carlo II d’Inghilterra iniziò a indossarla, durante il suo esilio all’Aia, seguendo la nuova moda, nonostante la difficile situazione che stava attraversando. Dopo il suo ritorno in patria e l’incoronazione del 1660, la cravatta si diffuse anche nella corte inglese. Da allora non è mai tramontata, anche se ha attraversato trasformazioni continue. La forma più diffusa attualmente iniziò a configurarsi tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.
L’Italia ha avuto un grande ruolo nell’evoluzione e diffusione della cravatta. La fortuna del prodotto italiano si è basata principalmente sulla qualità del tessuto, frutto di un complesso processo produttivo. A partire dagli anni Venti del XX secolo, Como è diventata il centro mondiale della moda serica e della cravatta in particolare, portando a compimento un’eredità che risale ai tempi in cui Ludovico il Moro favorì nell’area circostante lo sviluppo del morone (il gelso), dando il via a un primato nella produzione e lavorazione della seta durato secoli. Negli ultimi decenni la produzione si è spostata, per via dei costi molto inferiori, in Cina, ma Como è a tutt’oggi un’eccellenza nei prodotti in seta e nelle cravatte. Varie aziende italiane si sono affermate nel Novecento per l’eleganza e l’originalità delle loro creazioni: ricordiamo senz’altro Marinella, che non ha mai abbandonato la storica sede di Riviera di Chiaia a Napoli pur potendo contare su una vasta rete di distribuzione internazionale e perfino su un’esposizione al MoMa di New York. Ma le eccellenze sono diffuse nella penisola: Battistoni a Roma, Finollo a Genova, Cattaneo a Torino, Mosconi a Lipomo, in provincia di Como. Solide storie aziendali che si fondano sulla leggerezza dei tessuti e su una inesauribile creatività.