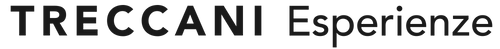Nella storia della musica è accaduto più volte che un’opera venisse poco apprezzata al suo esordio, o che addirittura fosse vittima di insuccessi clamorosi, con aperta contestazione da parte degli spettatori. Un destino comune a molti celebri compositori, spesso proprio in occasione della prima rappresentazione di quelle opere che in seguito sarebbero state tra le più acclamate, diventando vere e proprie pietre miliari.
La critica successiva ha attribuito di frequente il fiasco al carattere innovativo di alcune opere, che ha fatto sì che non venissero al primo ascolto comprese e apprezzate: in realtà, le motivazioni sono state diverse nelle varie occasioni. Bocciato dal pubblico fu persino Beethoven per il suo Fidelio, che andò in scena con l’originale titolo di Leonore, al Theater an der Wien (Vienna) il 20 novembre 1805. L’opera era forse troppo lunga, il clima politico particolare - Vienna da pochi giorni era stata occupata dalle truppe napoleoniche, che peraltro costituivano una buona parte del pubblico - ma l’insuccesso fu così eclatante che il compositore ritirò l’opera dalle scene per ripresentarla, rimaneggiata, solo nove anni dopo. Anche il grande Giuseppe Verdi fu protagonista di due clamorosi fiaschi, con la Traviata e con il Simon Boccanegra, sempre alla Fenice di Venezia, la prima il 6 marzo del 1853 e la seconda il 12 marzo 1857. E un’accoglienza negativa subì anche Giacomo Puccini per la sua Madama Butterfly, il 17 febbraio 1904 al Teatro alla Scala di Milano. Ma il caso più singolare rimane forse quello del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, contestata dal pubblico all’esordio il 20 febbraio 1816 al Teatro Argentina di Roma, e poi però subito apprezzata fin dalla prima replica, che valse all’opera un’immediata consacrazione. Una svolta così repentina da far parlare addirittura di complotto: in realtà Rossini aveva vissuto con preoccupazione l’attesa del debutto per alcune singolari circostanze.
Quando compose Il barbiere di Siviglia, il musicista doveva ancora compiere ventiquattro anni, ma era già un autore affermato, grazie soprattutto al successo di Tancredi e dell’Italiana in Algeri. Aveva persino assunto nel 1815 la direzione dei Teatri Reali di Napoli, il San Carlo e il Fondo, ma una speciale clausola gli consentiva di proporre le sue opere anche in altre città. Perciò accettò volentieri l’incarico che gli offrì il duca Francesco Sforza-Cesarini, impresario del Teatro Argentina di Roma, di inserire una sua opera inedita nella programmazione della stagione di Carnevale del 1816. Pensò allora di creare un nuovo adattamento di Le barbier de Séville ou la précaution inutile di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, di cui esisteva già una versione operistica di Giovanni Paisiello. Rappresentata per la prima volta a San Pietroburgo il 15 settembre 1782 al Teatro dell’Ermitage, presso la corte di Caterina la Grande, aveva avuto uno straordinario successo in tutta Europa e in Italia ed era ancora spesso portata in scena e apprezzata. La scelta di proporne una nuova versione costringeva a un paragone e poteva sembrare poco rispettosa nei confronti del celebrato Paisiello, che peraltro era ancora in vita e godeva comunque di grande popolarità, sebbene messo in difficoltà dalla restaurazione dei Borboni e non in buone condizioni di salute.
Rossini si mosse quindi con cautela, anche se le sue precauzioni si rivelarono beffardamente inutili, come è stato spesso sottolineato. In primo luogo, chiese il permesso a Paisiello di partire dalla stessa base da lui utilizzata trentaquattro anni prima: autorizzazione che gli fu concessa. Per evitare un confronto diretto, suggerì al librettista Cesare Sterbini, con cui aveva già collaborato nell’opera immediatamente precedente Torvaldo e Dorliska, di creare un testo nuovo nei versi e anche nelle situazioni. Decise inoltre di dare un titolo diverso all’opera, proponendola come Almaviva, o sia l’inutile precauzione, sempre allo scopo di evitare un parallelismo troppo stretto con il lavoro di Paisiello.
Il libretto fu pronto alla fine di gennaio e Rossini compose tutta la musica in una ventina di giorni. L’opera era infatti inserita in cartellone per martedì 20 febbraio, una settimana prima del martedì grasso e quindi otto giorni prima dell’inizio della Quaresima. Prima di andare in scena, come ultima precauzione, fu proposta anche una premessa scritta da Sterbini in cui si sottolineava il «rispetto e venerazione che animano l’Autore della Musica del presente Dramma verso il tanto celebre Paisiello che ha già trattato questo soggetto sotto il primitivo suo titolo»; una precisazione tesa a fugare il sospetto di «una temeraria rivalità coll’immortale autore che lo ha preceduto». Gli interpreti erano tutti di primo livello: Luigi Zamboni nei panni di Figaro, Bartolomeo Botticelli in quelli di Don Bartolo, il tenore spagnolo Manuel García nel ruolo del conte di Almaviva, Zenobio Vitarelli in quello di Basilio, mentre Rosina era interpretata dal contralto bolognese Geltrude Righetti-Giorgi, amica di Rossini e futura Cenerentola.
Rossini era fiducioso nella validità della musica e dei cantanti, ma quando arrivò il gran giorno della prima la reazione del pubblico fu subito negativa: fischi, schiamazzi e contestazioni disturbarono tutta la rappresentazione e Rossini stesso fu sbeffeggiato e insultato. Alcuni storici ipotizzano che questa bocciatura sia stata organizzata da qualcuno che voleva a tutti i costi l’insuccesso dell’opera: il rivale Teatro Valle, i teatri napoletani indispettiti dal 'tradimento autorizzato' di Rossini, lo stesso Paisiello. Non ci sono però riscontri in tal senso; l’unico indizio è l’immediato straordinario successo che Il barbiere di Siviglia ottenne fin dalla prima replica, in contrasto con una così violenta prima bocciatura.
Rossini, in due lettere successive alla madre, commenta così le diverse reazioni del pubblico: «Ieri sera andò in scena la mia opera e fu solennemente fischiata, o che pazzie, che cose straordinarie si vedono in questo paese […]. Vi dirò che in mezzo a questo la musica è bella assai e nascono di già sfide per la seconda recita dove si sentirà la musica, cosa che non accadde ieri sera mentre dal principio alla fine non fu che un immenso sussurro che accompagnò lo spettacolo». I toni della seconda lettera scritta dopo alcune repliche sono completamente diversi: «la seconda sera e a tutte le altre recite date non hanno che applaudita questa mia produzione […] applausi di un genere tutto nuovo e che mi fece piangere di soddisfazione». Il musicista pesarese sembra attribuire l’episodio alla ‘pazzia straordinaria’ del pubblico che emette sentenze inappellabili e al tempo stesso provvisorie, ed è forse proprio qui che risiede l’insondabile mistero di questa prima così sfortunata, per una delle opere poi più celebrate della storia della musica.
Crediti della foto
Uno spartito del Barbiere di Siviglia, Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna, foto di Palickap, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.