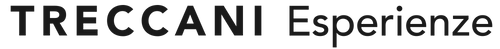Noi bandite da tutti gl’impieghi, avvilite dal sistema assurdo e snaturato di una frivola educazione, abbiamo disperato per molti secoli di vincere tanta barbarie, e di vedere il fine di tante ingiustizie. Si è ripetuto le mille volte, che noi siamo create per la felicità degli uomini. Essi però a vero dire colla loro condotta ci hanno dato sovente argomenti di credere, che sono stati creati per raddoppiare i nostri lacci, e per renderci nella società affatto passive. Cittadini, se voi spezzare volete le catene dei re, noi spezzare vogliamo anco le nostre.
Carolina Arienti Lattanzi, La schiavitù delle donne, 1797.
Il potere della moda esercitò sempre la sua influenza; ebbe vita attiva nei grandi movimenti politici, si mischiò nei partiti, si mostrò come l’espressione del pensiero, ora adottando le fogge di una nazione guerriera, ora i colori della libertà, dell’indipendenza, or quelli di una nazione prospera e tranquilla.
Corriere delle Dame, editoriale del 20 luglio 1848.
Le prime riviste femminili dedicate principalmente alla moda iniziarono a farsi strada in Francia nella seconda metà del XVIII secolo, svolgendo una funzione che in precedenza era stata affidata alle poupée de mode, le bambole che con i loro vestiti in miniatura avevano contribuito alla diffusione della moda francese nell’aristocrazia europea. Tra le pubblicazioni più note, Le journal des dames, fondato da Madame de Beaumer nel 1759, e La Cabinet des Modes, rinominato poi Magazin des modes nouvelles francais et anglaises nel 1789, a pochi anni dalla prima uscita (1785). Inizialmente queste riviste contenevano solo incisioni di figurini, accompagnate in seguito da brevi didascalie, ma nel tempo si arricchirono anche di veri e propri articoli dedicati a diversi temi di attualità, tra cui la politica, e cominciarono a farsi largo anche contenuti letterari.
I primi esperimenti italiani, caratterizzati da testi brevi ed eleganti bozzetti, presero spunto da questi precedenti francesi: il Giornale delle nuove mode di Francia e d'Inghilterra venne pubblicato a Milano dal 1786 al 1794, mentre La donna elegante ed erudita fu un’avventura editoriale veneziana durata solo pochi anni, dal 1786 al 1788. Ma l’esperienza più significativa e più duratura fu quella del Corriere delle Dame, pubblicato a Milano dal 1804 al 1875.
La prima direttrice della rivista fu Carolina Arienti Lattanzi, che la fondò insieme al marito, il giornalista romano Giuseppe Lattanzi. Di umili origini toscane, aveva trentacinque anni ed era già nota per le sue idee progressiste e per il suo impegno a favore dell’emancipazione delle donne. Nel 1797 aveva pubblicato La schiavitù delle donne in cui denunciava i limiti dei moti rivoluzionari dell’epoca che non affrontavano il nodo della libertà femminile: il Corriere delle Dame era dunque una testata che non si occupava soltanto di moda, ma era influenzata dalle idee rivoluzionarie della sua direttrice. Articolata in otto pagine, usciva con cadenza settimanale e arrivò in poco tempo ad avere un certo numero di abbonamenti (settecento nel 1811): un successo legato anche alla presenza di articoli che oltrepassavano i temi ritenuti all’epoca di specifico interesse femminile come la moda e l’accudimento dei figli, trattando anche di letteratura, teatro, arte e politica.
Nel 1815 Carolina Arienti Lattanzi pubblicò il suo Diario poetico, che venne distribuito alle abbonate come almanacco. Erano comunque sempre presenti numerosi bozzetti, spesso ripresi dalle riviste francesi, e uno spazio veniva riservato alla moda italiana e milanese, contribuendo a diffonderla e a sottolinearne il valore; ma l’aspetto interessante in questo ambito era la capacità di cogliere il significato sociale e politico della moda stessa, mai trattata in modo futile e superficiale. La rivista era inoltre all’avanguardia per la sua veste grafica e per le tecniche tipografiche impiegate, e i figurini erano proposti con preziose incisioni di rame. Contribuivano alla copertura dei costi le inserzioni a pagamento di botteghe artigiane e sartorie milanesi, che apparivano nelle pagine della rubrica Colpo d'occhio giornaliero della città di Milano, ossia annunzio di economia, arti e commercio che rappresentava, in considerazione del prestigio della rivista, un’ottima occasione per le imprese locali del settore. Invece, la rubrica Termometro politico era dedicata a informare sui fatti politici più rilevanti, che venivano commentati in un’ottica progressista e risorgimentale, con le dovute cautele rispetto alla censura.
Alla morte di Carolina Arienti Lattanzi, nel 1818, la direzione del giornale passò a Giuditta Lampugnani. Giuseppe Lattanzi si risposò con Vittoria Carolina Pozzolini, che divenne anche lei collaboratrice della rivista, cosicché la sigla C. L. - con cui la prima direttrice firmava i suoi articoli - continuò ad apparire sul Corriere delle Dame, utilizzata da Vittoria Carolina, omettendo il suo primo nome. Il profilo culturale della rivista non mutò neanche con la direzione di Angiolo Lambertini, che anzi accentuò il carattere patriottico della pubblicazione, soprattutto in occasione dei moti del 1848. Nel numero dell'8 aprile di quell’anno si descrive l’esaltazione per la positiva, in quella fase, evoluzione degli avvenimenti: «Milano non è più riconoscibile, tanta è la gioia, il brio, la concordia dopo la cacciata degli Austriaci». Si sottolinea inoltre il ruolo svolto dalle donne a sostegno alla causa dell’indipendenza italiana, prendendo come esempio la patriota Cristina di Belgioioso.
Interessanti sono le note sull’influenza del patriottismo sulla moda: la rivista registra il diffondersi del ‘costume alla lombarda’, che viene indossato anche dai combattenti delle Cinque Giornate, e ne pubblica i figurini sia della versione maschile sia di quella femminile, entrambe caratterizzate dalla presenza del velluto nero e del ‘cappello alla calabrese’. L’uso del velluto locale era motivato dal tentativo di boicottare l’industria della lana tedesca, cosicché il ‘cappello alla calabrese’ si configurava come un omaggio alla rivolta del 1847, tanto che la polizia austriaca, nel febbraio 1848, mise al bando i ‘cappelli alla calabrese’, quelli ‘all’Ernani’ e quelli ‘alla puritana’, per la diffusa interpretazione in chiave risorgimentale delle opere di Verdi e di Bellini. Nel 1859 i patrioti adottano come moda l’uniforme piemontese e il Corriere delle Dame commenta: «Ormai per la toeletta di un giovane elegante è indispensabile l'uniforme militare, colla virtù e la coscienza di ben portarla».
La rivista interpretava sempre prontamente lo spirito del tempo, offrendo una lettura politica della moda largamente condivisa. Dopo il raggiungimento dell’Unità nazionale, il Corriere delle Dame non mutò il suo indirizzo, rimanendo sempre legato anche al tema dei diritti delle donne. Alla testata principale si affiancarono, dopo il 1848, il Corriere delle mode e La ricamatrice, che avevano un contenuto più specifico e settoriale. Nel 1875 l’editore Sonzogno decise di chiudere tutte e tre le riviste e inserire i loro contenuti in spazi specifici su pubblicazioni di carattere generale. Finiva così la gloriosa storia del Corriere delle Dame, che aveva accompagnato, con diverso sguardo, così importanti passaggi della società italiana.
Crediti della foto
Moda di Parigi, Corriere delle Dame, 18 luglio 1845, N. 40, Pubblico dominio, Collection Online Rijksmuseum.