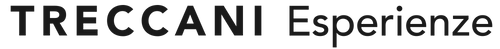Il sipario è un elemento essenziale nel teatro: svolge un ruolo attivo, separa la finzione dalla realtà, delimita lo spazio come quarta parete, apre e chiude il tempo della rappresentazione ed è la prima cosa su cui si posa lo sguardo del pubblico nell’atmosfera vibrante che precede lo spettacolo.
Il sipario ha accompagnato l’evoluzione del teatro nelle diverse epoche attraverso cambiamenti di aspetto e di funzioni. In particolare, con lo sviluppo della scenografia pittorica a partire dal XVII secolo, si aprì la grande tradizione dei sipari dipinti, fiorita poi nei secoli appena successivi. Già nel Settecento, grazie alle loro raffinate immagini, queste grandi tele arricchivano i teatri, catturando lo sguardo del pubblico seduto in sala in attesa delle rappresentazioni e durante la preparazione delle scene, ed erano considerati una sorta di titolo aggiunto, figurativo, delle opere. All’epoca, la loro realizzazione era affidata perlopiù agli scenografi, ma spesso si ricorreva anche all’intervento dei decoratori della sala teatrale, come se il sipario fosse parte integrante dell’architettura del teatro: una parete dipinta che apparteneva alla sua struttura, pur accompagnando lo svolgersi degli spettacoli in programma.
Nel corso dell’Ottocento, lungo la nostra Penisola, nacquero molti nuovi teatri, che fin da subito assunsero un ruolo di rilievo nelle comunità locali, come prestigioso monumento cittadino. Il sipario partecipava pienamente a tale funzione simbolica, perciò la committenza cominciò a rivolgersi a valenti pittori e non più agli scenografi.
La produzione restava comunque complessa e passava attraverso varie fasi: il bozzetto, la scelta e la preparazione del tessuto (anche per adattarlo alle dimensioni necessarie), la pittura vera e propria con l’impiego di diverse tecniche, la protezione e, infine, le rifiniture che rendevano la tela un effettivo sipario pronto all’uso.
Nella seconda metà del secolo per l’influenza della pittura storica, le tele cominciarono ad affollarsi di figure che spesso evocavano le glorie cittadine: in alcuni casi, assunsero quasi il carattere di manifesti politici, esaltando valori e appartenenze, mentre altre volte celebravano in modo più specifico la funzione civilizzatrice dell’arte.
Un esempio particolarmente significativo è il sipario storico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, opera di Francesco Coghetti portata a compimento nel 1861. Dopo venticinque anni di assenza, questo capolavoro è stato finalmente ricollocato al suo posto originario, a seguito di un importante intervento di restauro, concluso nel maggio 2025 e possibile grazie a una donazione di AgriEuro srl e al cofinanziamento del Comune di Spoleto. Il degrado dei sipari storici si deve spesso alla loro funzione e alle tecniche di movimentazione, che ne provocano un’inevitabile usura: in questo caso, il sipario di Spoleto, realizzato con tempere magre su una ridotta preparazione, presentava importanti criticità, come segni di umidità, deformazioni della tela e scuciture. Inoltre, il suo restauro risultava particolarmente complesso anche per le notevoli dimensioni, pari a 11,90 metri in altezza e 13,92 metri in larghezza.
La tela rappresenta in modo vivo e dinamico la Disfatta di Annibale sotto Spoleto: in basso viene raffigurata la battaglia, mentre in alto, da un bastione, la popolazione spoletina getta l’olio bollente sugli assalitori, riproducendo così un leggendario episodio di storia locale ed esaltando la valorosa resistenza all’invasore. Lo scontro è stato ricostruito sulla base delle parole di Tito Livio: «Annibale per la via breve attraverso l'Umbria giunse a Spoleto. Saccheggiato il territorio, avendo cominciato ad assalire la città ed essendo stato respinto con grande strage dei suoi, intuendo delle forze di resistenza di una semplice colonia, con infelice esito aggredita, qual grave impresa sarebbe stata quella di un assalto a Roma, deviò il cammino verso il territorio del Piceno» (Ab Urbe Condita, XXII, 9). Da questo resoconto, si intuisce che fu proprio l’eroica difesa di Spoleto a convincere il generale cartaginese a rinunciare ad attaccare direttamente Roma. Un ruolo epico peraltro esaltato anche da Giosue Carducci in Alle fonti del Clitunno: «Deh come rise d’alma luce il sole/per questa chiostra di bei monti, quando urlanti vide e ruinanti in fuga/l’alta Spoleto/i Mauri immani e i numidi cavalli/con mischia oscena, e, sovra loro, nembi/di ferro, flutti d’olio ardente, e i canti/de la vittoria!».
Il Teatro Nuovo di Spoleto, dedicato a Gian Carlo Menotti nel 2010, venne costruito e inaugurato nel 1864 su iniziativa della Società degli Azionisti, che raccoglieva un gruppo di cittadini illustri, tra cui spiccava, anche per cospicui contributi economici, la figura di Filippo Marignoli, futuro senatore del Regno. I membri della Società scelsero loro, dopo un lungo confronto, il soggetto da raffigurare sul sipario per poi affidarne l’esecuzione a Coghetti, che aveva già realizzato nel 1856 il sipario per il teatro Comunale di Rimini (Cesare passa il Rubicone).
La realizzazione della Disfatta di Annibale sotto Spoleto non fu un episodio isolato, perché la produzione di sipari dipinti si diffuse rapidamente nell’Italia del tempo. Il pubblico era molto attento alla qualità di queste grandi tele, poiché non erano un elemento secondario per il prestigio del teatro, anzi. Tuttavia, molti pittori erano restii ad accettare questo tipo di incarichi, perché potevano sembrare meno importanti rispetto ad altre commissioni e al tempo stesso presentavano grandi difficoltà tecniche nella realizzazione. Per altri fu invece un’occasione per farsi conoscere e alcuni diventarono degli specialisti del settore: come il romano Cesare Fracassini che, negli anni Sessanta del XIX secolo, creò splendidi sipari per il Teatro Argentina (Numa che ascolta i consigli della Ninfa Egeria), per il Teatro Apollo (Apollo che consegna a Fetonte il carro del Sole, colle Ore e l'Aurora) e per il Teatro di Orvieto (Orvieto assediata da Goti e liberata da Belisario).
Tra le tante realizzazioni, merita una menzione anche il sipario del Teatro San Carlo di Napoli, dipinto nel 1855 da Giuseppe Mancinelli e accolto con entusiasmo dal pubblico cittadino. L’opera raffigura un ideale Parnaso, in cui sono riunite le più eminenti personalità della civiltà antica e moderna, con al centro la triade formata da Omero, Virgilio e Dante. Altre pitture importanti furono realizzate a Padova da Vincenzo Gazzotto, a Cervia da Giovanni Canepa, a Pieve di Cento da Adeodato Malatesta, a Cento da Antonio Mussi.
Tele preziose, che raccontavano storie antiche contaminate dagli ideali risorgimentali dell’epoca, oppure esaltavano il ruolo dell’arte e della letteratura nell’elevare l’animo umano. In molti casi i sipari che hanno subito i danni del tempo restano nei magazzini, inutilizzati e non visibili: il ritorno dello storico sipario al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti, presentato per la prima volta al pubblico durante il Festival Dei Due Mondi di Spoleto 2025, è un importante passo in una diversa direzione e ci ricorda quanto la memoria storica del teatro sia intrecciata alla vocazione contemporanea di quest’arte.
Un invito a raggiungere Spoleto, dove il teatro continua a essere un incontro vivo tra epoche e linguaggi: preparati allo spettacolo del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Scopri l’Esperienza.