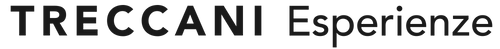Nel centro di Roma, a pochi passi da Porta Maggiore, sono visibili i resti di un sepolcro databile tra la fine dell’età repubblicana e i primi anni dell’età augustea (30-20 a.C.) che presenta caratteristiche molto particolari, per forma, decorazione e soprattutto per il ruolo delle persone a cui è dedicato. Per identificarle, ci è di aiuto l’iscrizione riprodotta nei tre lati: «est hoc monimentum Margei Vergilei Eurysacis pistoris redemmptoris apparet» (questo è il sepolcro di Marco Virgilio Eurisace, panettiere, appaltatore di forniture pubbliche e apparitore – ossia ufficiale subalterno di un sacerdote o di un magistrato). Colpisce dunque la maestosità della sepoltura a fronte di una professione tutto sommato umile come il pistor, il fornaio, che ci porta però a immaginare un forte ritorno economico.
Nella tomba, all’interno di un panario (un’urna a forma di cesta per il pane), erano conservate anche le spoglie della moglie Atitia, morta prima del marito e da lui ricordata con parole di lode nell’epigrafe a lei dedicata, oggi custodita presso il Museo Nazionale Romano. I due coniugi compaiono insieme nel rilievo in marmo restaurato ed esposto nella Sala Colonne della Centrale Montemartini di Via Ostiense, su cui si vede Eurisace con indosso una toga e Atitia con una tunica coperta dalla stola. Il monumento funebre, dunque, celebra l’amore coniugale e al tempo stesso rende omaggio all’arte di panificare. Infatti, oltre all’urna di Atitia, sono molti gli elementi e i dettagli che rimandano la professione di Eurisace. Basti pensare alle cavità circolari e ai piloni cilindrici, tuttora ben visibili, che evocano a livello simbolico due strumenti fondamentali per la professione di fornaio: gli stai per la farina e i lunghi contenitori in cui lievitava il pane. Particolarmente significativo è anche il lungo fregio posto sulla sommità del monumento, che riproduceva tutte le fasi del lavoro: pesatura e molitura del grano, preparazione dell’impasto, cottura nel forno e vendita del pane. Tutte operazioni condotte sotto la sorveglianza dello stesso Eurisace.
Si ipotizza che Eurisace fosse un liberto, cioè uno schiavo liberato, e il suo cognome fa pensare a un’origine greca, condizioni entrambe molto frequenti fra quanti esercitavano allora la professione. La sua bottega aveva raggiunto le dimensioni di una piccola impresa: Eurisace, come si è detto, si definisce ‘appaltatore’ quindi produceva il pane anche per lo Stato e rivendica la sua qualifica di ‘apparitore’, ovvero delegato o procuratore di qualche magistrato. Era dunque un uomo che partendo dal basso aveva costruito una posizione economica talmente solida da potersi permettere una sepoltura così magnifica.
È andato perduto il lato principale della struttura, che si presentava di fronte a chi entrava a Roma dalla via Labicana o dalla Prenestina. L’area, dove erano presenti anche altre sepolture, ha mutato aspetto molte volte nel corso dei secoli. In primo luogo, con l’edificazione di Porta Maggiore, voluta dall’imperatore Claudio nel 52 d.C. per consentire al suo nuovo acquedotto (l’Aqua Claudia, che passa proprio sopra la porta) di scavalcare le vie Prenestina e Labicana. Il sepolcro fu poi inglobato nelle mura quando l’imperatore Aureliano tra il 270 ed il 275 volle modificare l’assetto difensivo, mentre durante il regno di Onorio (393-423) fu incorporato in una torre che non lo rendeva più visibile. Soltanto nel 1838 il sepolcro di Eurisace e Atitia fu riportato alla luce, attraverso la demolizione delle modifiche alle mura realizzate da Onorio. E così l’omaggio alla professione dei fornai è tornato a farsi ammirare e a incuriosirci.
Ma quale era il loro ruolo nella società romana? Nel I secolo a.C., cioè all’epoca di Eurisace, erano attivi circa 350 panettieri a Roma. L’introduzione del pane nella dieta dei romani era però relativamente recente e aveva accompagnato una trasformazione alimentare, economica e culturale, avvenuta nel secolo precedente. Per molto tempo, il piatto alla base dell’alimentazione dei Romani era stata la polta, una sorta di polenta di farina di farro (puls) cotta in acqua salata, un cibo piuttosto ‘primitivo’ e talmente diffuso che Plauto coniò per definire i romani dell’epoca uno scherzoso neologismo derivato dal greco: pultiphagonides, ossia “divoratori di polta”, che ricorda in qualche modo il moderno ‘polentoni’. Il bollito di orzo, meno apprezzato, veniva riservato agli schiavi e ai soldati; altri cereali di ampio consumo, ma considerati meno appetibili, erano anche la segale e l’avena. Con il farro vennero in seguito preparate le focacce, una sorta di pane primitivo e senza lievitazione e questo cereale è rimasto a lungo il più utilizzato nell’antica Roma, fino alla comparsa del grano, più produttivo e più facilmente coltivabile.
Il consumo del pane, lievitato, si diffuse e divenne accessibile a tutti soltanto nell’ultimo periodo della Repubblica Romana, ed era collegato al miglioramento della situazione economica della città, al dominio sul Mediterraneo, allo sviluppo della flotta, dei porti e del commercio via mare. Il pane accompagnò mutamenti profondi della società romana e non è un caso che Marco Porcio Catone, tenace difensore delle antiche virtù romane, non approvasse il rapido progredire della produzione del pane, che collegava al declino dei costumi e dei valori tradizionali, mentre auspicava un ritorno alla polta e alla focaccia non lievitata. I cambiamenti dei costumi avevano però radici profonde e l’alimentazione era parte di una tendenza che si dimostrò inarrestabile. Secondo Plinio, le prime panetterie romane aprirono intorno al 171 a.C. e le attività di panificazione furono sviluppate anche con il sostegno dello Stato, che riteneva centrale sfamare la crescente popolazione della città, anche attraverso distribuzioni gratuite di grano (frumentationes) o di pane, che fruttarono ai pistores favorevoli contratti. I fornai ottennero una serie di privilegi e crearono una propria corporazione. Alcuni di loro si arricchirono, come il laborioso Eurisace che utilizzò parte dei suoi proventi per erigere un monumento funebre che celebrasse, in eterno, l’importanza di questa professione.
E la storia del pane è una storia eterna; un impasto di saperi, materie selezionate e gesti che resistono al tempo. E, oggi, il ricordo dei fornai e dei mugnai antichi sopravvive ancora nei laboratori contemporanei, dove le farine continuano a raccontare storie straordinarie e il territorio e dove il pane è ancora un rito da rispettare: un tesoro.
Scopri le farine biologiche tra le eccellenze delle Langhe: parti per Tesori d’Alta Langa.
Crediti della foto
Foto di Byus71, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons